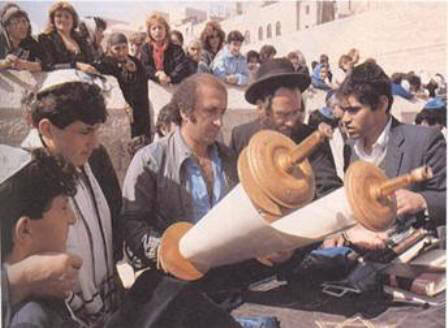LE TAPPE FONDAMENTALI NELLA VITA DI UN EBREO
di Marco Saule |
L’ebraismo è un sistema di vita in cui tutti i momenti sono vissuti
anche su un piano religioso. L’esistenza di un ebreo, dal momento in cui
nasce a quando la vita l’abbandona, è disciplinata da una serie di norme
che regolano i suoi comportamenti e segnano i limiti della sua attività
terrena.
Le fasi attraverso le quali il singolo diventa parte del popolo e si
mette in sincronia con esso sono: la circoncisione all'inizio della
vita, la maggiorità religiosa nel passaggio dalla pubertà
all’adolescenza, il matrimonio e la creazione di una nuova famiglia
nell’età adulta ed infine la morte. LA NASCITA E LA CIRCONCISIONE
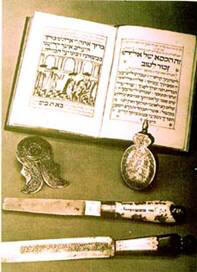 La
nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza
ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo
giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste
nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale
maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in
ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e
nella comunità di Israele. La
nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza
ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo
giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste
nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale
maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in
ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e
nella comunità di Israele.
La circoncisione oltre al significato più immediato di patto con Dio, ne
ha un altro meno manifesto e conosciuto: il numero otto ha un
significato simbolico che implica ciò che va oltre il naturale. E’ come
se l’uomo attraverso la circoncisione si assumesse la responsabilità di
perfezionare la natura stessa e l’opera del creatore.
La circoncisione deve essere compiuta all’età di otto giorni e non può
essere rinviata se non per gravi problemi di salute del neonato. La sera
prima della circoncisione si usa riunirsi per una serata di studio in
segno d’augurio per il neonato.
L’obbligo della circoncisione ricade sul padre che generalmente delega
questo compito ad un circoncisore, in ebraico mohèl. Alla cerimonia, nel
corso della quale viene anche annunciato il nome del bambino, sono
presenti anche parenti ed amici.
Quando nasce una femmina si fa una festa nel corso della quale le viene
imposto il nome. Tale cerimonia prende il nome di Zeved Ha-bat, cioè il
dono della figlia. In passato dopo ottanta giorni dalla nascita di una
femmina la madre si recava al Santuario per offrire il sacrificio, come
prescritto dalla Torà, e per presentare alla Comunità la nuova nata. La
cerimonia consta di tre momenti: la lettura di brani biblici, la
benedizione augurale alla neonata, la benedizione sacerdotale.
Generalmente in questa occasione la madre recita la Benedizione per lo
scampato pericolo, essendo il parto considerato come pericolo per la
donna. Nell'antica Giudea quando un neonato nasceva, un albero era
piantato per solennizzare la nascita. In seguito quando il ragazzo o la
ragazza erano alla vigilia del matrimonio, il "loro" albero era tagliato
per ricavarne i pali che sarebbero poi serviti per il baldacchino
nuziale.
Un altro momento importante sempre nella prima infanzia è quello del
riscatto del primogenito, che avviene a trenta giorni dalla nascita. La
cerimonia ricorda in particolar modo l'ultima piaga che colpì gli
egiziani, la morte dei primogeniti. La nascita del primo figlio può
indurre l'uomo a sentirsi potente e creatore, è necessario dunque che
riconosca che tutto quanto egli riceve gli proviene invece dal Creatore.
L'atto del riscatto consiste nel consegnare ad un discendente dalla
famiglia di Aronne (cioè ad un cohèn) cinque monete d'argento (sheqalìm)
che in genere sono poi devolute in beneficenza. LA CERIMONIA DEL BAR MIZWÀ
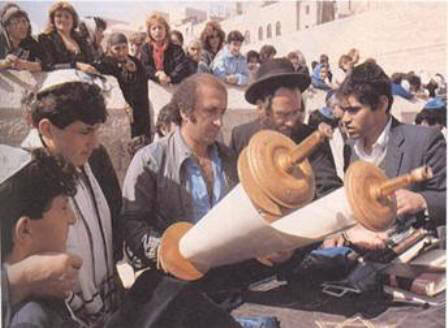
Lo studio ha sempre avuto nell'ebraismo un significato particolare,
anche perché è attraverso lo studio che si trasmettono le tradizioni e
si perpetua la Torà. I genitori hanno il compito di educare i propri
figli e di trasmettere loro il patrimonio culturale fino a che il
ragazzo non diviene responsabile del proprio comportamento morale e
religioso. Questo avviene quando compie tredici anni e diventa Bar Mizwà,
cioè impegnato a tutti gli effetti all’osservanza delle norme ed entra a
far parte del numero degli adulti che formano la Comunità.
Questa tappa segna il passaggio ad una vita religiosa responsabile, e da
questo momento cessa per il padre l'obbligo di sorvegliare i doveri
religiosi del figlio.
In quest’occasione il ragazzo indossa per la prima volta il talleth
(manto) per la preghiera e i tefillin (filatteri) che sono involucri di
pelle nera in cui vengono inserite pergamene con brani biblici. In
sinagoga egli deve leggere tutta la parte della Torah prescritta per
quel giorno.
Per l'ebraismo ortodosso alle bambine non è riservato alcun rito
speciale. Dal XIX secolo in poi, l'Ebraismo riformato ha introdotto una
cerimonia religiosa anche per le bambine. Per le ragazze l’onore e
l’obbligo di osservare le tradizioni iniziano a dodici anni e non a
tredici. Secondo la legge ebraica, una ragazza raggiunge la sua maturità
"legale" a dodici anni e un giorno.
Le ragazze celebrano in questo giorno la loro entrata nel mondo dei
precetti con una cerimonia detta Bat Mizwà, simile a quella dei maschi.
Così come succede per i ragazzi, è uso in questo giorno festeggiare. |
IL MATRIMONIO EBRAICO Il matrimonio e la
procreazione fanno parte dei doveri degli uomini e delle donne ebree. Il
rapporto tra marito e moglie è monogamico (non si può essere sposati a
più di una persona per volta) ma non è inscindibile (è possibile
divorziare).
Il matrimonio ebraico può essere celebrato solo fra ebrei, quindi i
matrimoni cosiddetti "misti" che avvengono nei paesi della diaspora,
hanno solo valore civile.
In antichità i Rabbini stabilirono come limite massimo per contrarre
matrimonio l'età di 20 anni, perciò chi aveva superato questo tempo
senza essersi sposato era ritenuto inadempiente alle regole. Ora, per il
cambiamento delle condizioni sociali ed economiche, questa regola è
caduta in disuso anche presso le famiglie più fedeli.
Il matrimonio è da una parte un accordo privato tra marito e moglie,
codificato da un contratto nuziale la Ketubà, e dall’altro un impegno
che la coppia assume nei confronti della Comunità, in ottemperanza a
quanto scritto nella Genesi e cioè: “Crescete, moltiplicatevi e popolate
la terra”. Per l'ebraismo la vita solitaria è una sventura, il
matrimonio senza figli un disastro e una buona moglie il maggior bene
che si può augurare ad un uomo.
La cerimonia del matrimonio ebraico si svolge preferibilmente all’aperto
sotto un baldacchino nuziale i cui quattro angoli simboleggiano la casa
che la coppia costruirà a partire da quel giorno.
La celebrazione nuziale è molto complessa e si divide in tre atti
distinti, il primo, il Shiddukhim, è considerato una sorta di
fidanzamento: l'uomo chiede in sposa la donna la quale esprime il suo
consenso. La fase successiva, i Kiddushim, si svolgono alla presenza di
due testimoni ed è l'atto in cui lo sposo, pronunciando la formula "Tu
sei destinata a me per mezzo di quest’anello secondo la legge di Mosè e
Israele", dichiara di riservare a sé la donna prescelta consegnandole,
dopo aver ottenuto il suo consenso, un anello e impegnandosi attraverso
la Ketubà a fornirle il mantenimento, il vestiario, ad adempiere ai suoi
obblighi coniugali e a metterle a disposizione una somma che le sarà
pagata in caso di divorzio o di cui lei potrà usufruire alla morte del
marito.
Al termine della cerimonia lo sposo infrange un bicchiere per ricordare
che nessuna cerimonia può considerarsi completamente lieta dopo la
distruzione del tempio di Gerusalemme e l’allontanamento dalla Terra
Santa del popolo eletto.
LA MORTE
Il concetto ebraico del rispetto dei morti esige che vengano sepolti
al più presto e nel modo più austero possibile. Dopo aver sepolto il
parente, viene effettuata una lacerazione su un indumento dei congiunti
più stretti (figli, coniuge, genitori, fratelli) e da quel momento essi
devono attenersi alle regole di lutto strettissimo per una settimana.
Tale periodo è detto “shivà”. Durante la shivà i congiunti devono
compiere riti specifici, astenersi dal lavoro e rimangono in casa,
seduti su bassi sgabelli o in terra per ricevere i visitatori che
vengono a porgere le condoglianze.
Alla shivà seguono gli “sheloshim”, un periodo di trenta giorni in cui
pur riprendendo le occupazioni normali si osservano alcuni particolari
riti e preghiere e ci si astiene da qualsiasi divertimento. Le regole
per il lutto divengono con il passare del tempo meno rigide e l'ebraismo
prescrive che, per quanto il dolore per la perdita di una persona cara
sia indelebile, chi ha subito un lutto deve tornare ad una vita normale.
Dopo dieci o undici mesi ha luogo la commemorazione annuale che inaugura
il monumento funebre, in genere una lapide con la data di morte e
qualche frase commemorativa.
Cimitero ebraico di Praga
Il corpo del defunto è lavato, rivestito con un sudario di lino bianco e
posto in una semplice bara di legno senza ornamenti. Il morto poi viene
condotto al cimitero dove si cantano dei versetti biblici e liturgici da
parte del rabbino che guida il corteo funebre verso il luogo della
sepoltura.
I partecipanti usano fare delle soste lungo la via come espressione del
loro dolore.
Di solito si tiene un elogio funebre o nella cappella o mentre la bara è
posta nella fossa. A questo punto i partecipanti maschi aiutano a
ricoprire la fossa di terra. Si recitano le tradizionali preghiere per i
defunti e i partecipanti porgono parole di consolazione ai familiari.
Davanti alla tomba si recita il Kaddish, brano che verrà ripetuto per
tutto il periodo del lutto, e ad ogni anniversario.
Per il primo pasto dopo la sepoltura, è dovere preparare per i parenti
in lutto un uovo sodo. L'uovo è il simbolo della vita: è rotondo, non ha
quindi né un punto d’inizio né uno di fine, così come la vita che, dopo
la morte della persona, continua e deve continuare attraverso i suoi
discendenti. Esso ricorda ai rimasti che la morte, pur nel più completo
rispetto e nel ricordo dello scomparso, non deve rappresentare un
momento di frattura e di disperazione totale, perché la vita continua in
questo mondo e nell'aldilà. |
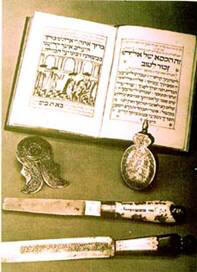 La
nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza
ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo
giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste
nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale
maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in
ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e
nella comunità di Israele.
La
nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza
ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo
giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste
nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale
maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in
ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e
nella comunità di Israele.