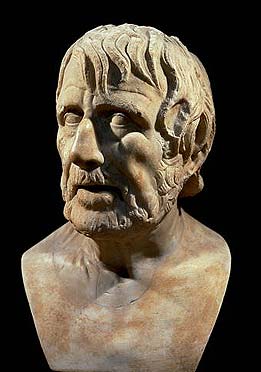 |
SENECA (4a.C.-65d.C.)
Lucio Anneo Seneca, uno dei più grandi autori latini, nacque a
Cordova nel 4a.C. da ricca famiglia, andò a Roma per completare la
sua formazione. Nel 41d.C., salito al trono l'imperatore Claudio,
Seneca fu accusato d’adulterio, e fu mandato in esilio in Corsica
dove rimase fino al 49d.C., quando gli fu concesso di ritornare a
Roma. Alla morte dell’imperatore Claudio, Seneca ricevette
l'incarico di educare il giovane principe Nerone (54d.C.). Quest’ultimo,
grazie agli insegnamenti del maestro, governò in un primo tempo con
moderazione, dando importanza al senato e al ceto aristocratico,
come aveva fatto in precedenza l'imperatore Augusto. Col tempo,
però, Nerone si rivelò un despota, che fece uccidere la madre
Agrippina e il suo consigliere Burro. Seneca, deluso dal
comportamento di Nerone, nel 62d.C., decise di allontanarsi dalla
vita di corte per tornare alla vita solitaria. Nel 65d.C. Nerone
condannò al suicidio Seneca accusandolo di essere uno dei
cospiratori della congiura ordita contro di lui da Pisone. |
|
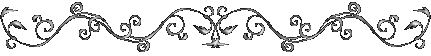
La produzione letteraria di Seneca è molto ampia, tra le sue
opere maggiori ricordiamo: le "Epistolae morales ad Lucilium" e il
"Dialogum libri". Quest’ultimo è una raccolta di dieci dialoghi, tre dei
quali appartengono al genere della consolatio: "Consolatio ad Marciam", "Consolatio
ad Helviam matrem", "Consolatio ad Polybium", essi risalgono,
probabilmente, al periodo dell’esilio. Questo tipo d’opera era già usato in
precedenza da filosofi greci e romani per alleviare il dolore a chi aveva
subito dei lutti o la perdita dei beni.
Nella "Consolatio ad Marciam", Seneca, consola l'amica Marcia, figlia
dello storico Cremuzio Cordo, perché aveva perso un figlio di soli tre anni.
Da questo testo traspare la visione di Seneca della morte, vista come
liberazione da tutti i mali.
"La morte è la risoluzione di ogni dolore e la fine, oltre la quale i
nostri mali non vanno, la morte ci ripone in quello stato di tranquillità in
cui giacemmo prima di nascere. Se qualcuno compiange i morti deve
compiangere anche in non nati. La morte non è né un bene né un male; può
essere un bene od un male ciò che è qualche cosa, ma ciò che di per se è
nulla e a nulla riduce il tutto, non ci affida ad alcuna fortuna.[...] Tuo
figlio è uscito dai confini entro i quali si è schiavi, lo ha accolto una
pace grande ed eterna; non viene attaccato dalla paura della povertà, dalla
preoccupazione per la ricchezza, dagli stimoli del capriccio, che attraverso
il piacere rode l'animo, non viene toccato dall'invidia per i successi
altrui, non è schiacciato da quella per il proprio, neppure da qualche
offesa le orecchie vereconde sono colpite; non è vista all' orizzonte
nessuna rovina dello Stato, nessuna privata; per la preoccupazione del
futuro, non resta sospeso ad un risultato che sempre si volge a situazioni
ancor più incerte. Finalmente si è fermato là, da dove nulla può scacciarlo,
dove nulla può atterrirlo."("Consolatio ad Marciam" 19 5-6)
Secondo Seneca la morte,
liberazione da tutte le sofferenze, offese e
preoccupazioni della vita, non deve essere temuta perché coincide con il
nulla, anzi, egli nel dialogo "De providentia" sostiene che quando il
peso della vita diventa insostenibile è ammesso il
suicidio. "Non sempre
bisogna cercare di tenere la vita, perchè vivere non è un bene, ma è bene
vivere bene"(Ep.70).
Accanto all'aspetto tradizionale della morte concepita come liberazione,
Seneca affianca un elemento di originalità: l'idea che l'uomo, anche se non
se ne rende conto, muore giorno per giorno: infatti anche se si è soliti
considerare la morte come qualcosa di lontano, gran parte di essa è già
stata vissuta perchè tutto il tempo che è già trascorso appartiene alla
morte.
"Moriamo ogni giorno, ogni giorno infatti ci viene sottratta una parte della
vita e anche quando noi cresciamo la vita decresce...questo stesso giorno
vivendo lo dividiamo con la morte"(Ep 24,20).
|