|
Gli abissi |
La parte più profonda di un
oceano è distinta dagli studiosi in piana abissale (la fascia tra i 2.000 m
e i 6.000 m di profondità) e in zona adale (anche detta ultraabissale, la
fascia che supera i 6.000 m, fino alle fosse oceaniche). Le fosse
oceaniche, occupano poco più dell’1% di tutta la superficie dei fondali,
esse però non si trovano nelle zone centrali degli oceani ma in posizione
periferica, vicino al margine dei rilievi, sia emersi, sia sottomarini.
Fosse di questo tipo circondano tutto l'Oceano Pacifico (fossa delle
Aleutine, del Giappone, delle Marianne e Perù-Cile), parti dell'Oceano
Indiano (fossa dell'Indonesia) e l'Oceano Atlantico (sistemi arco - fossa
delle Indie Occidentali e della Nuova Scozia). Alcune tuttavia, sono lontane
da qualunque area continentale, come la fossa Romanche nell'Atlantico
equatoriale e le fosse Vema e Diamantina nell'Oceano Indiano. Quella più
profonda è la fossa delle Marianne, che raggiunge gli 11.022 m nell'abisso
Challenger, dove si è immerso nel 1960 il batiscafo abissale Trieste.
 Gli abissi sono situati nella zona afotica ovvero quella non illuminata
dalla luce solare, distinta dalla zona diafana che si estende fino ai 200 m
di profondità. Procedendo verso il basso, la temperatura dell'acqua tende a
diminuire: a 2000 m si registra una temperatura di 3°C e a 3000 m di soli
2°C, sui fondali si può sfiorare lo zero. La pressione invece aumenta,
un'atmosfera ogni dieci metri. Il mare profondo è dunque un ambiente
estremo, abitato da pochi organismi che non sono mai vegetali a causa
dell’assenza di luce. Alcuni animali, proprio a causa di questa oscurità,
sono divenuti essi stessi luminosi costituendo la sola fonte di luce in
questo splendido ambiente. Gli abissi sono situati nella zona afotica ovvero quella non illuminata
dalla luce solare, distinta dalla zona diafana che si estende fino ai 200 m
di profondità. Procedendo verso il basso, la temperatura dell'acqua tende a
diminuire: a 2000 m si registra una temperatura di 3°C e a 3000 m di soli
2°C, sui fondali si può sfiorare lo zero. La pressione invece aumenta,
un'atmosfera ogni dieci metri. Il mare profondo è dunque un ambiente
estremo, abitato da pochi organismi che non sono mai vegetali a causa
dell’assenza di luce. Alcuni animali, proprio a causa di questa oscurità,
sono divenuti essi stessi luminosi costituendo la sola fonte di luce in
questo splendido ambiente.
 Alcune specie sono luminescenti in permanenza, altre emettono luce solo di
quando in quando: nel periodo della riproduzione, come segno di
riconoscimento della specie, per vedere, per attirare una possibile preda o
per spaventare un nemico. L'oscurità degli abissi ha permesso ad alcune
forme di vita di trasformare la loro capacità visiva, alcuni pesci sono
diventati totalmente ciechi mentre altri hanno occhi molto grandi. Alcune specie sono luminescenti in permanenza, altre emettono luce solo di
quando in quando: nel periodo della riproduzione, come segno di
riconoscimento della specie, per vedere, per attirare una possibile preda o
per spaventare un nemico. L'oscurità degli abissi ha permesso ad alcune
forme di vita di trasformare la loro capacità visiva, alcuni pesci sono
diventati totalmente ciechi mentre altri hanno occhi molto grandi.
 Altra
caratteristica essenziale che distingue questi organismi abissali dai
"normali" pesci è che sono carnivori: alcuni hanno mascelle deformate per
ingoiare prede a volte più grandi di loro, altri invece si nutrono
d’organismi morti caduti sul fondale, quest'ultimi sono detti anche
saprofagi. Lasciando da parte i pesci, che costituiscono la principale
caratteristica della vita abissale, il fondale è frequentato anche da
spugne, da ricci, da anemoni, da crostacei, da oloturie, da stelle di mare,
da molluschi e proprio uno di quest'ultimi è forse il più leggendario
abitante dei fondali marini: Altra
caratteristica essenziale che distingue questi organismi abissali dai
"normali" pesci è che sono carnivori: alcuni hanno mascelle deformate per
ingoiare prede a volte più grandi di loro, altri invece si nutrono
d’organismi morti caduti sul fondale, quest'ultimi sono detti anche
saprofagi. Lasciando da parte i pesci, che costituiscono la principale
caratteristica della vita abissale, il fondale è frequentato anche da
spugne, da ricci, da anemoni, da crostacei, da oloturie, da stelle di mare,
da molluschi e proprio uno di quest'ultimi è forse il più leggendario
abitante dei fondali marini:
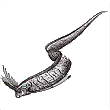 il calamaro gigante (Architeuthis), considerato
il più grande invertebrato finora noto e preda preferita dei capodogli. La
sua lunghezza arriva fino ai 21 m, compresi i tentacoli armati di ventosa. il calamaro gigante (Architeuthis), considerato
il più grande invertebrato finora noto e preda preferita dei capodogli. La
sua lunghezza arriva fino ai 21 m, compresi i tentacoli armati di ventosa.Ma le fosse oceaniche non sono solo l’ambiente naturale di strane specie animali, sono anche legate a fenomeni di vulcanismo e terremoti, a loro volta collegati con quella teoria scientifica che è chiamata “Tettonica delle Placche”.  I grandi vulcani della Terra, quelli con la familiare forma a cono con un cratere alla sommità, si sono sviluppati per la maggior parte lungo margini di continenti che sono fiancheggiati da fosse abissali, oppure fanno parte d’intere catene d’isole vulcaniche anch’esse accresciutesi lungo le fosse. Sono tutti vulcani altamente esplosivi, i cui prodotti, in gran parte piroclastici (scorie, lapilli, ceneri e polveri), sono di natura da intermedia (o neutra) ad acida (andesiti e rioliti), anche se non mancano prodotti più basici (basalti). Allo stesso modo le fosse sono collegabili a fenomeni sismici rilevanti. Gli ipocentri vanno da superficiali (a ridosso della spaccatura) a progressivamente molto profondi (man mano che ci si allontana); sono distribuiti lungo una superficie ideale che scende all’interno della Terra con un’inclinazione tra i 30 e i 70 gradi, fino ad oltre 700 km di profondità. Tale superficie è nota come superficie di Benioff (dal nome del sismologo russo che, nel 1954, la mise in evidenza). Le fosse oceaniche sono un elemento importante del movimento dei continenti, esse rappresentano, infatti, i margini distruttivi (o di convergenza) delle singole placche, dove la litosfera, divenuta col tempo fredda e densa, viene distrutta nel processo di subduzione. Questa discesa di una placca sotto l’altra dà luogo a moltissimi terremoti, dovuti al loro attrito, ed è “segnalata” dalla superficie di Benioff; il fatto che dopo i 700 km di profondità questi fenomeni sismici cessino, porterebbe a pensare che oltre quella profondità la placca in subduzione sia ormai completamente fusa nel mantello sottostante. |